François Rabelais

François Rabelais (Chinon, 1483 o 1494 - Parigi, 9 aprile 1553) è stato uno scrittore, umanista, medico e frate francescano francese che nel suo romanzo Gargantua (1534) ha descritto una società utopica basata su un unica regola: «Fa' quel che vuoi».
Biografia [1]
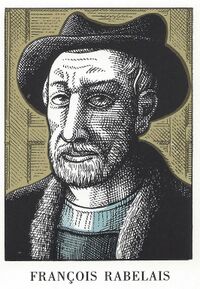
François Rabelais è stato uno scrittore che meglio ha interpretato il Cinquecento francese nei suoi aspetti più inventivi e fecondi, ma anche più complessi e inquietanti. La sua arte contraddittoria e per certi versi enigmatica non cessa di affascinare per la densità linguistica e metaforica delle sue immagini, la forza creativa dei suoi paradossi, la vertigine parodica di una visione del mondo nella quale il travestimento comico non va mai disgiunto da quello simbolico.
Al pari della sua opera, anche la biografia di François Rabelais presenta a tutt'oggi alcune zone d'ombra, a cominciare dalla data di nascita, incerta tra il 1483 e il 1493. Altri dubbi riguardano la sua vocazione e la scelta del monachesimo, presto abbandonato a favore della medicina e delle lettere, ma recuperato in seguito nei suoi testi dove la satira religiosa si accompagna all'affermazione più o meno scoperta delle tesi evangeliche collegate alla Riforma. È comunque all'ambito ecclesiastico che occorre rivolgersi per le prime notizie certe sulla sua vita: nel 1521 Rabelais si trova infatti nel monastero francescano di Fontenay-le-Comte, nel Poitou, dove la corrispondenza con il grande umanista Guillaume Budé testimonia uno studio assiduo della lingua e della filosofia greche. Risale a questo periodo il celebre episodio del "ratto" dei libri greci che il giovane monaco conserva nella sua cella contro le regole dell'ordinamento francescano.
È un evento significativo che testimonia l'inizio della vocazione umanistica all'origine del suo primo cambiamento di stato: dall'ordine dei Francescani a quello più intellettuale dei Benedettini. Questa soluzione tuttavia non basta a Rabelais, che di lì a qualche anno depone definitivamente la tonaca e parte alla scoperta del mondo.
Nel settembre del 1530 si iscrive alla facoltà di medicina di Mont-pellier, dove prepara un commento degli Aforismi di Ippocrate condotto sull'originale greco e attraverso nuovi manoscritti da lui ritrovati. L'interesse per la medicina, unito allo scrupolo dell'umanista che non si accontenta degli intermediari della cultura medievale, ma intende risalire all'origine delle cose e alla conoscenza dei fatti della natura, anticipa e prepara la visione rinascimentale dell'uomo come unità inscindibile di corpo e anima che pervade l'intera opera letteraria di Rabelais. Abbandonata temporaneamente la medicina, nel 1532 Rabelais pubblica il Pantagruel, primo libro delle gesta dei giganti Pantagruel e Gargantua costruito sulla parodia dei romanzi cavallereschi secondo il modello dei poemi eroicomici di Pulci e di Folengo; la seconda edizione dell'opera viene condannata per ragioni di moralità dalla Sorbona. Dopo un viaggio a Roma al seguito del vescovo e futuro cardinale Jean du Bellay, Rabelais scrive un nuovo episodio romanzesco incentrato sulla figura di Gargantua, approfittando della grande notorietà delle Croniques Gargantuines, redazioni anonime e molteplici di una leggenda popolare basata su racconti orali.
Nel 1534 esce la Vie inestimable du Grand Gargantua père de Pantagruel e viene colpita anch'essa da censura.
Solamente la protezione della famiglia Du Bellay consente a Rabelais di ottenere dal re il privilegio di pubblicare i suoi libri, peraltro sistematicamente condannati dalla Sorbona per le loro tesi apertamente rivoluzionarie e anticlericali. A questi primi due testi seguono il Tiers livre (1546), dove la ricerca irrisolta della donna ideale dell'avventuriero Panurge finisce per coincidere con la ricerca del sapere e della felicità secondo lo schema di un romanzo di formazione che ha anche i caratteri dialogici del convito socratico, e il Quart livre che, in antitesi al percorso ideale del testo precedente, narra il viaggio reale di Pantagruel e dei suoi compagni verso il santuario della Dive Bouteille, moderna parodia dell'oracolo delfico al quale chiedere il responso definitivo, e la cui sentenza paradossale ma inevitabile consiste nell'invito ad abbandonarsi al furore dionisiaco del vino. Dopo la morte di Rabelais, avvenuta nel 1553, esce postumo il frammento dell'lle sonante (1562), contenente sedici capitoli del Cinquième livre, pubblicato interamente nel 1564 e ritenuto dalla critica un rifacimento anonimo sulla base di un canovaccio dello stesso Rabelais.
Il mondo alla rovescia e il codice della parodia [1]
Il motivo intorno al quale si concentrano l'opera e il pensiero di Rabelais è quello del viaggio, inteso metaforicamente come una riscoperta dell'uomo e del mondo. Il perenne viaggiare dei protagonisti, che mescola elementi della narrazione utopistica alla parodia delle epopee classiche e di viaggi reali (come ad esempio la spedizione di Jacques Cartier in Canada) va interpretato soprattutto come un'avventura spirituale che tende a sovvertire le gerarchie della realtà per proclamare un nuovo ordine. Nato dal caos delle forme, il gigante di Rabelais raffigura l'uomo che sceglie di dare voce ai propri desideri, intraprendendo il suo cammino di verifica e di liberazione nei riguardi della cultura mortificante dell'ascetismo e della rinuncia. L'ottimismo antropologico di Rabelais e la sua straordinaria originalità creativa si uniscono a una satira implacabile degli idola del suo tempo, dalla falsa religione alla giustizia illecita, alla cultura morta dei pedanti che limita l'universo spirituale dell'uomo, esemplificata nel catalogo esilarante della biblioteca di Saint-Victoir, parodia del sapere libresco e polveroso su cui si esercita la satira dell'umanista.
Le scelte tematiche e stilistiche di Rabelais e la vitalità esuberante della sua scrittura comica possono essere ricondotte, come fa ad esempio il critico russo Michail Bachtin, alle categorie del realismo grottesco e del carnevalesco, espressioni liberatrici e gioiose della cultura comica popolare del Medioevo, opposta alla visione ufficiale e gerarchica del mondo. Secondo Bachtin il tratto caratteristico del realismo grottesco risiede nel principio corporeo presentato nel suo aspetto materiale, comico e festoso, nel quale sono impliciti l'abbassamento e il rovesciamento dei valori tradizionali, ossia il trasferimento di tutto ciò che è alto, spirituale e astratto, sul piano materiale e corporeo.
Numerosi elementi della retorica narrativa di Rabelais, quali l'insistenza sugli atti corporei del bere, del mangiare e dell'attività sessuale, le immagini culinarie universalizzate, il ricorso al linguaggio popolare e agli stilemi della piazza, come l'ingiuria e l'esagerazione iperbolica, e soprattutto il rovesciamento parodico delle posizioni ufficiali della cultura e della religione, secondo Bachtin testimoniano l'appartenenza alla letteratura carnevalesca. Per quanto indubbiamente seducenti, le ipotesi di Bachtin svelano il lato più scopertamente vitalistico del comico in Rabelais, ma non ne esauriscono tutte le valenze.
Affrontando il discorso da un'altra prospettiva, la critica più recente ha indagato altri aspetti meno evidenti dell'opera di Rabelais, come il rapporto mai interrotto con la cultura alta rappresentata dalle fonti classiche, dal neoplatonismo e dall'evangelismo, attirando l'attenzione sull'effettiva ambivalenza dei testi e l'impossibilità di disgiungere il comico dal metafisico. A questo proposito si è notato che nel passaggio dai primi due testi dell'epopea al Tiers e Quart livre, il personaggio di Pantagruel subisce un progressivo mutamento, al termine del quale perde i tradizionali attributi del romanzo picaresco desunti dalla tradizione del poema eroicomico per divenire un sovrano dotato di inalterabile dignità e perfezione morale, erede della saggezza insieme antica e moderna di Socrate e di Erasmo da Rotterdam.
La religione di Rabelais e il problema dell'incredulità nel XVI secolo [1]
Partendo dal presupposto che nel Cinquecento l'incredulità dovuta a ragioni di ordine storico risulta un anacronismo rispetto allo spirito dell'epoca, lo storico francese Lucien Febvre ha tentato di sondare le posizioni religiose di Rabelais, accusato di ateismo e di oscenità dai contemporanei, in rapporto alle correnti evangeliche e riformate del secolo. La censura che colpisce Rabelais con particolare severità nel 1542 secondo Febvre è collegata all'arresto dell'umanista Étienne Dolet, stampatore di Gargantua e di Pantagruel e vicino agli ambienti riformati.
D'altro canto nell'opera di Rabelais vi sono numerosi riferimenti al catechismo dei riformatori, quali gli accenni al Vangelo come unica guida contro l'abuso dei falsi profeti, l'abolizione di un culto ostentato a favore della preghiera interiore, gli echi del pensiero di Lutero e soprattutto di Erasmo, mentre risulta evidente la sua condanna dell'intolleranza di Calvino.
La critica più recente ha sviluppato queste indicazioni, rilevando come uno degli esempi più accreditati dell'antimonachesimo di Rabelais e della sua satira anticlericale, la descrizione dell'abbazia utopistica di Thélème, edificata secondo il principio del libero soddisfacimento dei desideri, sia in realtà lo sviluppo narrativo di un passaggio della vita di san Girolamo di Erasmo. Lo stesso precetto del Fais ce que voudras, che rappresenta l'emblema stesso di Thélème, appare come un mascheramento, in chiave umanistica e riformata, del Quod vis fac di sant'Agostino, che Rabelais reinterpreta nel senso della responsabilità del libero arbitrio indicata da Erasmo. Sotto il travestimento comico di Rabelais si cela dunque una "riscrittura" letteraria del catechismo riformato che rivela ancora una volta l'alta densità semantica del testo.
L'abbazia di Thélème: l'utopia di Rabelais
Per premiarlo del valido aiuto prestatogli nella guerra contro Pricocole, Gargantua concede a fra' Giovanni Fracassatutto di fondare un'abbazia a suo piacimento, «al contrario» di tutte le altre. La costruzione architettonica, come i costumi dei thelemiti, si ispirano a un senso di totale libertà e apertura, di raffinata gioia di vivere. La fiducia nella naturale bontà degli uomini, garantita da una libera educazione, è alla base dell'armonia di questa ideale città felice. Rabelais consacra gli ultimi sei capitoli del primo libro a Thélème. Si tratta di uno strano insieme di testi: vi si trova, con la critica del mondo monacale, una proposta di vita ideale, che non coincide però completamente con il programma educativo di Panocrate. L'episodio si chiude con una iscrizione il cui senso resta misterioso. Al tempo stesso modello ed enigma, Thélème è un luogo «altro», «diverso», un'utopia, che pure non sfugge all'ottica ambigua che investe ogni episodio del romanzo.
Tutta la loro vita trascorreva non secondo leggi, statuti e regole, ma il libero volere e il franco arbitrio. Si alzavano quando lo credevano opportuno, bevevano, mangiavano, lavoravano e dormivano quando ne avevano desiderio; nessuno li svegliava, né li forzava a bere, a mangiare, o a far questo o quello. Così aveva deciso Gargantua. La regola, quindi, consisteva in un solo dettame: FA' QUEL CHE VUOI, perché le persone libere, bennate, ben istruite, che hanno modo di conversare in oneste compagnie, posseggono per natura un istinto e un pungolo che le spingono sempre verso la virtù, e le allontanano dal vizio, ed è ciò che chiamano onore. E son coloro che, quando una vile soggezione o imposizione li deprimono e li fanno schiavi, volgono ogni nobile passione, per la quale tendevano liberamente alla virtù, a infrangere o piegare il giogo della servitù; perché noi vogliamo sempre fare cose proibite e desideriamo quel che ci è negato. [2]
L'utopia di Rabelais secondo Maria Luisa Berneri [3]

Lo stesso Rabelais è un tipico uomo del Rinascimento. La sua cultura enciclopedica, la sua profonda ammirazione per la letteratura greca, il suo odio per le dottrine scolastiche, il suo cristianesimo pagano, il suo disprezzo per la vita monastica, il suo amore per la libertà e la bellezza, sono tutte caratteristiche degli umanisti italiani. Come loro, egli aveva una vera passione per la conoscenza e non solo studiò letteratura e filosofia, ma anche medicina e giurisprudenza. Inoltre, come la maggior parte degli umanisti, non provava alcun interesse per i «problemi sociali». La sua ribellione fu puramente individuale e non l'associò ad una rivolta contro il sistema di società. Vide i mali della società del suo tempo, ma non cercò di trovare la loro causa né escogitò rimedi per essi. Il Rinascimento non fu un movimento di riforma, fu una ribellione di individui che cercavano la libertà principalmente per loro stessi. Nonostante il loro nome, gli umanisti non s'interessavano dell'umanità, ma della loro individualità e dei mezzi per esprimerla, si irritavano profondamente per qualsiasi interferenza da parte delle autorità civili o religiose ed erano profondamente consapevoli dei loro diritti, ma non lottavano per la libertà o per i diritti delle masse. L'Abbazia di Telème è qualcosa di più che una descrizione di una corte ideale, o di un ideale collegio, o, come l'interpretò Mumford, di un'ideale casa di campagna. È l'utopia della nuova aristocrazia del Rinascimento, un'aristocrazia basata sull'intelligenza e sulla conoscenza piuttosto che sul potere o la ricchezza. Rabelais descrive come vivevano questi uomini e donne di buona famiglia, educati, dotati e di bell'aspetto. Per loro non c'è bisogno di leggi e di legislatori, di politici e di predicatori, di denaro e di usurai, di religione e di monaci. Non han bisogno di alcuna norma perché essi sanno come impiegare il loro tempo nel modo più utile e piacevole, non han bisogno di alcuna costrizione morale esterna perché sono naturalmente onesti e pieni di nobili sentimenti. Godono di piena libertà e di completa parità tra uomini e donne. Nulla può esser troppo meraviglioso e sontuoso per uomini e donne che sono, per così dire, il fiore dell'umanità. Vivono in un castello che supera per magnificenza quelli della Turenna, son vestiti cogli abiti più ricchi, hanno un benefattore i cui fondi sono evidentemente senza fine ed un esercito di inservienti e di artigiani che li servono e forniscono loro ogni cosa di cui abbiano necessità [...]. L'educazione ricevuta dai telemiti è tale da confarsi a futuri prìncipi o uomini di corte ed è del tutto simile a quella prescritta dal Castiglione per l'ideale cortigiano del Rinascimento [...]. Questa educazione, come quella ricevuta dai «monaci e dalle monache» dell'Abbazia di Teleme, può creare un alto livello di perfezione individuale, ma è curiosamente slegata da qualsiasi fine utilitaristico. I telemiti non paiono esser destinati ad intraprendere alcuna utile professione o mestiere, ma ad avere per tutta la loro vita uno stuolo di servitori ai loro comandi. È anche improbabile che troveranno molto gusto in un lavoro che è semplicemente l'esercizio del corpo o della mente, ma che non è finalizzato a creare qualcosa di utile. Non si può fare a meno di aver l'impressione che, nonostante tutta la sua magnificenza, la vita nell'Abbazia di Rabelais ben presto sarebbe divenuta monotona e la noia si sarebbe impadronita dei telemiti, come in effetti s'impadronì di molti prìncipi e cortigiani anche nelle corti più brillanti. Ad onore di Rabelais si deve ricordare, tuttavia, che nella sua comunità ideale non esiste né re né principe da adulare e divertire. Queste osservazioni sarebbero state superflue se molti, spinti dall'entusiasmo per il famoso motto rabelaisiano «Fa' quel che vuoi», non si fossero dimenticati che egli lo riservava solamente per i: «[...] freschi, giocondi, allegri, piacevoli, graziosi: e tutti in generale gentili compagnoni [...] dame d'alta stirpe, con franco cuore e liete, fiori di bellezza dal viso celeste, dal corpo snello, dal fare onesto e saggio».
L'utopia di Rabelais secondo Marcel Dieu [4]

Non bisogna cercare di scoprire nell'opera di Rabelais ciò che non vi è ed ancor meno non bisogna cercare di far dire a Rabelais quello che non ha mai detto e scritto. Ciascuno ricordi il prologo di Gargantua: «Bisogna aprire il libro e pensare attentamente ciò che vi è raccontato. Allora voi conoscerete che la droga che vi è racchiusa ha un valore ben diverso di quello che la scatola prometteva: cioè che la materia che vi è trattata non è così leggera come il titolo pretendeva». Se per esaltare questo grande uomo, si dovesse piegare il suo pensiero agli imperativi di una dottrina sociale, filosofica od etica – fosse pur essa anarchica – sarebbe meglio rinunciarvi subito, perché si commetterebbe la peggiore aberrazione e l'insulto che si farebbe a Rabelais ricadrebbe immancabilmente sul nostro ideale al quale renderemmo il peggiore dei servizi. Per questo io cercherò di estrarre da questa sostanziale materia, tutto quello che può arricchire le nostre idee, tutto quello che può risvegliare risonanze amiche e fraterne con il nostro pensiero anarchico, eternamente sveglio ed alla ricerca costante di tutto ciò che può vivificarlo ed abbellirlo. L'idea fondamentale sulla quale Rabelais cerca di costruire la sua opera, è che la natura è buona e benigna all'uomo. Rabelais proclamerà sempre che bisogna seguire la natura con fiducia e che bisogna stare in guardia contro quelle severe discipline sempre invocate per giustificare pretenziose sorveglianze, il cui scopo è di correggere la signora perbene. In questo modo Rabelais riabilita l'uomo, quell'altro mondo, come egli si compiace definirlo nel corso di tutta la sua opera. Dell'uomo, centro di gravità, magnifica scoperta che il Rinascimento esalterà con passione, Rabelais dirà tutto il valore supremo, quel valore che deve essere rispettato a tutti i costi. Non sorprende, quindi, di trovare in Rabelais l'odio per la guerra «ciò che i Saraceni ed i Barbari una volta chiamavano eroismo noi ora lo chiamiamo brigantaggio e cattiveria». Questo odio lo riporta sui conquistatori la cui mentalità insensata e criminale si esprime in tutto il suo Gargantua. Così l'uomo ha il suo vero posto e Rabelais gli restituisce la sua libertà intera e gli dice: «Fa' quello che tu vorrai». Tutto questo è essenzialmente rivoluzionario e necessita un nuovo indirizzo nell'educazione. Rabelais se n'era reso conto perfettamente poiché iniziava un nuovo sistema pedagogico. Che egli sia rimasto incompreso dai suoi contemporanei, egli che tentava di sostituire alla maniera scolastica di moda un'educazione naturale, non c'è affatto da stupirsi. È ancora Rabelais che enuncerà quel meraviglioso pensiero: «Scienza senza coscienza non è che la rovina dell'anima». Egli è l'iniziatore di una nuova filosofia e questa filosofia (espressa nel Pantagruel) è la vittoria progressiva dell'uomo sulla natura. Non cerchiamo tuttavia di scoprire in Gargantua e in Pantagruel di Rabelais un'esposizione di dottrine politiche o sociologiche. Niente di tutto questo e neppure qualche cosa di prossimo. Ma cercando bene vi si scoprirà qualche cosa di meglio, gli elementi di ciò che io chiamerei una politica personale. La sua opera rimane, quindi, un contributo prezioso per il suo tempo e si presenta indiscutibilmente come un rinnovamento del libero pensiero. La letteratura scritta su Rabelais è grandiosa. Quella che io ho utilizzato per questo mio lavoro, lo posso dire senza falsa modestia, ed in onore di chi mi ha aiutato a comprendere Rabelais, è la migliore e la più ragionevole, se faccio eccezione di qualche opera secondaria. Ho provato un immenso piacere di trovare fra tutte le opere da me consultate lo studio di Ginguené De l'autorité de Rabelais dans la revolution présente et dans la constitution civile du Clergé (1879). Della sua introduzione riproduco qualche brano che ci conferma tutto quello che noi abbiamo intravisto, leggendo, meditando, ripensando ed annotando l'insieme dell'opera di Rabelais.
«Voglio dare a Rabelais solo ciò che gli è dovuto, tirarlo fuori dall'oblio in cui è lasciato, ricordare che aveva disprezzato il culto di certi idoli che noi abbiamo adorato ancora due secoli dopo di lui, e che la sua autorità dev'essere messa tra quella dei saggi che hanno preparato la distruzione delle nostre sciocchezze politiche e religiose».
Il merito di Ginguené è di aver attirato l'attenzione sul contenuto del pensiero dell'opera di Rabelais e si può affermare che dopo quell'opuscolo, molti cessarono di considerare il libro sotto un aspetto unicamente umoristico d'un raccontatore spiritoso e divertente. Ho sentito dire che, nel 1853, Eusèbe Salverte pubblicò otto articoli nella Revue Encyclopedique in cui non solo lodò il pregiato scrittore, ma anche il pensatore, «il più gaio dei filosofi francesi che si è servito della follia per interpretare la saggezza. Certamente che egli ha avuto il presentimento che senza agire in quel modo, non sarebbe stato ascoltato. Erasmo, prima di lui, aveva seguito lo stesso metodo nell'Elogio della pazzia». Félix Dubois, nel capitolo "La Dottrina" del suo libro Le peril anarchiste ricorda i precursori dell'anarchia. Senza risalire a Platone, egli si accontenta di raccogliere nel sedicesimo secolo e ricorda che l'anarchismo ha preso da Rabelais la famosa frase: «Fa ciò che vuoi». E seguita, presentandoci il Nostro come precursore dell'ideale anarchico:
«L'allegro curato di Meudon ha creato nell'abbazia di Telemaco una società ideale, una riunione di uomini ubbidienti agli stessi istinti, che si compiace di ricordare la propria esistenza... Così, dice Rabelais, nessun vincolo, nessuno di quegli statuti fondamentali delle così dette società organizzate; nessun limite alla libertà individuale; gli anarchici non predicano diversamente».
È questo un modo paradossale di presentare l'anarchia, ma non vale la pena di polemizzare con l'autore di Peril Anarchiste. Anche se la sua opera è ben documentata, certe parti sono ispirate dalla fantasia. Max Nettlau in Bibliographie de l'Anarchie ricorda che François Rabelais enumera i precetti dell'Abbazia di Telemaco che potrebbero essere ancora quelli di coloro che praticano l'anarchismo. Piotr Kropotkin in La Scienza Moderna e l'Anarchia dice:
«Nello stesso modo in cui il movimento anabattista del sedicesimo secolo, che inaugurò e fece la riforma, aveva un fondo anarchico... così Rabelais nella prima metà dello stesso secolo, Fenelon verso la fine del XVII secolo e, soprattutto l'enciclopedista Diderot, nella seconda metà del XVII, svilupparono le stesse idee, che trovarono qualche applicazione pratica durante la Grande Rivoluzione».
Yves Guyot e Sigismond Lacroix, nella loro Histoire des Proletaires, non mancarono di vedere in Rabelais l'uomo del Rinascimento:
«Egli ride di un grande riso che passa sulle cose sante, sulle autorità costituite come un soffio di tempesta, e le danneggia talmente che molte rimangono rovinate per sempre».
Consultando il dizionario del XIX secolo del Larousse, ecco che cosa trovo:
«In mezzo agli avvenimenti del XVI secolo, nel momento in cui la grande secessione religiosa preparava la guerra civile ed accendeva i roghi, lo spirito di Rabelais fu un diversivo alle lotte dei partiti. Strana e potente epoca! Il movimento prodigioso dell'intelligenza produsse il Rinascimento; la scienza e le arti sbocciarono e fiorirono, la filosofia nacque, il medioevo agonizzava, il nuovo pensiero stava germogliando, i roghi scoppiettavano, il sangue scorreva da tutte le parti, ed in mezzo a questi contrasti ed a questi antagonismi, si sente risuonare l'immenso scoppio di riso di quel Democrate gallico, di quell'Omero buffone la cui opera monumentale non perirà mai, non solo per la sua potente originalità, non solo perché vi si trova origini della nostra lingua, ma perché dietro lo scetticismo, lo scherzo irreligioso e la pazza immaginazione, vi si sente una critica superiore e dei giudizi eccellenti, un vivo amore per l'umanità, la passione della giustizia e il culto della scienza e dell'arte».
È certo che nel corso della storia, diversi Rabelais sono stati ricordati; ciascuno dei suoi ammiratori o detrattori ha intravisto l'uomo o l'opera sotto aspetti molto differenti. È certo che le lodi vanno di pari passo con le diffamazioni ed oggi ancora gli educatori continuano a presentare ai giovani un Rabelais talmente purgato che fa pietà sentire come parlano di un'opera così piena di vita e di filosofia. Rabelais è dominato non solo da un'ardente passione per la scienza ma anche, ed è ciò che vale di più, per la libertà di pensiero che egli esalterà con una gaiezza che nessuno aveva fatto prima di lui. Tutto questo sembra pericolosamente rivoluzionario, così si continuerà a deformare gli scritti o a lasciare sussistere leggende grottesche accreditate stupidamente nel corso degli anni, con la complicità dei grandi e con quella dei valletti servili, devoti all'ordine costituito. La mania di tutti coloro che sono fedeli al passato è sempre stata quella di ridurre e di purgare: persino Anatole France, un giorno facendo una conferenza su Rabelais davanti ad un eletto uditorio di Buenos Aires e di Montevideo, incominciò con un piacevole preambolo che informava i suoi ascoltatori che egli prenderebbe tutte le precauzioni per evitare di offendere il pudore più ombroso e le orecchie più suscettibili. Così, dunque, Rabelais può ancora scandalizzare ai nostri giorni quel mondo di benpensanti che, purtroppo, è senza cervello e senza giudizio. Avrebbe potuto scegliere un altro soggetto, quel Crainquebille della convenzione e dei pregiudizi, ma l'abilità di Anatole France è così grande che di un'esposizione scabrosa ne fa qualche cosa di presentabile persino a dei catecumeni. A che cosa serve, la perfezione di stile, la facilità oratoria, se diventano complici indirette di un pensiero che non osa esprimersi in tutta libertà? Ho molto apprezzato le riflessioni di Paul Souday, il quale ricordando il Rabelais d'Anatole France, dice:
«La sua filosofia naturalista o naturista, ispirata direttamente all'antichità, chiudeva il medioevo ed inaugurava il pensiero moderno. È un po' comico pretendere che egli non fosse un pensatore... Dispiace che Anatole France, per delle convenienze locali, abbia quasi fatto delle concessioni».
Rabelais ebbe molti detrattori ed io accennerò a qualcuno di quei valletti che presentarono Rabelais come un monaco scettico, buffone e cinico, personaggio poco raccomandabile, fuori programma per certuni, che bisognava mettere in quarantena ed impedire che la gioventù sfogliasse le pagine truculenti della sua opera. Si ricorderà che Ronsard lo dipinse come un ubriacone ed una specie di Panurge; più vicino a noi un La Bruyére non poté perdonargli di avere seminato lordura nei suoi scritti, ed infine quel triste Brunetière scrisse: «Ha meritato veramente di essere chiamato l'incantatore della canaglia» e continuerà aggiungendo: «getta sulla sua opera delle manate di fango che si scavalcano turandosi il naso». Si può constatare che in tutti i secoli quando si è trattato di eliminare o distruggere l'espressione del pensiero sovversivo, i procedimenti sono sempre stati gli stessi. Per questo sono contento di salutare in Rabelais un precursore delle nostre idee anarchiche. Che cosa importano i brontolii dei letterati, sempre pronti ad urlare con i lupi per diffamare ed insultare coloro che si rifiutano di pestare nello stesso fango? Ciò che vi è di notevole nel Nostro è il suo rifiuto di arrivare a delle conclusioni dogmatiche. Nei suoi scritti c'è da accontentare tutti i gusti. Dalla sua «fontana fantastica» sgorgano impressioni confortevoli in cui si mescolano la satira mordente e la facezia libera, ma da tutto questo ne esce una morale, una filosofia generosa e forte. Rabelais sviluppa in un'esposizione meravigliosa sull'educazione, la necessità di armonizzare l'evoluzione del corpo con quella dell'anima. Egli sostituisce alle astrazioni, dei fatti visibili e tangibili, perché è tanto con la vista quanto con i libri che ci istruiamo. Tutti questi pensieri sono stati ripresi da tutti i nostri che hanno scritto o messo in pratica dei tentativi d'insegnamento razionale e libertario (basti pensare a F. Ferrer e alla sua Scuola Moderna, a Sébastien Faure e alla sua Ruche, a Paul Robin, Frainet e a tanti altri). La politica di Gargantua è quella dei pensatori del XVI secolo, ancora impregnata di tradizione della Grecia e di Roma. È l'arte di governare i popoli nel significato più esteso che ha la parola arte. Con Rabelais c'è qualche cosa di nuovo che annuncia la Rivoluzione francese. Lo Stato non è tutto.
«Di fronte a lui si erge l'individuo, ancora incerto, ma forte della coscienza del suo valore personale e dei suoi diritti».
Ebbene, questa osservazione di Martin-Dupont, è l'origine d'una affermazione che io qualifico libertaria. E lo stesso Martin-Dupont dirà:
«Nei grandi movimenti verso l'individualismo che si fanno a quell'epoca e dei quali il Rinascimento e la Riforma sono le manifestazioni più originali, complementari l'una dell'altra, arte e coscienza, Rabelais ha un ruolo importante. Nessuno meglio di lui seppe riunire nello stesso grado il genio del Rinascimento e quello dell'antica Gallia, il passato classico ed il passato nazionale. Sotto questo aspetto egli ha un posto tra i precursori della Rivoluzione».
Aprite il suo libro, scorretelo con attenzione e troverete, in ogni passo dei suoi migliori capitoli, il canto della libertà. Osservatelo quando ruggisce. Gli abusi vi sono denunciati con forza, è un vento che soffia e sradica i pregiudizi più solidi. Panurge, questo buon Panurge, così umano e così vicino al popolo si drizza e con uno scoppio di riso fantastico vocifera contro le iniquità sociali. Che cosa importa che egli sia non solo superbo e nobile, ma qualche volta osceno, dal momento che egli protesta contro l'ingiustizia delle leggi? Abel Faure ne L'individu et l'Esprit d'autoritè, opera meravigliosa in cui parla dell'educazione francese in rapporto all'individualismo e allo spirito d'autorità, mostra sotto quella doppia evoluzione questi due principi che si oppongono continuamente nella storia, fa rilevare da questo combattimento omerico quel principio vitale che chiama in vita le forze latenti, l'individualismo da cui sgorga la linfa che feconda l'attività umana, contro l'altro principio malefico che impone all'individuo le sue leggi, ed arresta tutto, canalizzando e mettendo dighe all'uomo vivo, ostacolando la libera espansione della natura per fabbricare l'uomo-automa che si piega sotto l'arbitrio del giogo. Ricordando il XVI secolo, Abel Faure scrive:
«Questo secolo fu grandissimo, il più grande della nostra storia, per il coraggio e la ostinata energia che mostrarono i grandi individualisti, più fecondo in risultati felici del XVIII secolo che noi mostreremo infestato da certi elementi corrotti della filosofia sensualista. Questo secolo vide Rabelais, Montaigne, Ramus, la Riforma. Questi nomi sintetizzano, caratterizzano tutti gli individualismi: filosofico, umanistico, teologico: libertà di religione, libertà di pensiero, libertà estetica. Individualismo che tenta di liberare gli uomini, ciascuno alla propria maniera, con l'educazione... ciò che li distingue è la loro volontà di essere degli educatori. Non lo sono più istintivamente come prima ma essi pongono chiaramente e decisamente il problema dell'educazione. Noi vedremo questi diversi elementi di libertà alle prese con il principio d'autorità del secolo».
Certo, Rabelais è sensuale e violento, ma ha lo spirito aperto al culto del bello e del bene, mescolato alla franca gioia puramente animale. Rabelais si fa amare per quello che egli ha di sensibile e di intellettuale. La nostra struttura mentale è capace di comprendere i colpi che il Nostro, nascosto e protetto dalla buffoneria e dall'enormità, assesterà ai pedanti ed ai teologi. È il trionfo del libero esame. Lo scetticismo ha conquistato certi cervelli. Rabelais è veramente un uomo, se non con la ragione, almeno di temperamento.
«Il libro di Rabelais è dunque venuto a tempo; nato dalle circostanze, prodotto dall'ambiente. Cinquant'anni dopo, gli uomini sarebbero stati troppo spirituali; cinquant'anni prima troppo volgari e materialisti».
Rabelais ha impresso alla sua opera un sentimento che caratterizza tutti i suoi scritti: la solidarietà umana. Può darsi che certuni, leggendolo, non vi trovino affatto quel genere di solidarietà che si manifestò più tardi nella filosofia contemporanea che la forza dell'assioma ha falsamente sviluppata. Rabelais è più semplice e la sua solidarietà non s'allontana dalle frontiere del buon senso e del buon umore. Se egli denuncia con veemenza la ambizione dei signori e dei principi che per un sì o per un no dichiarano la guerra ai loro vicini, egli ammira con non meno forza lo spirito di coloro che si sforzano di conservare la pace tra gli uomini di buona volontà.
«Immaginare ferite e colpi è una cosa troppo semplicista e troppo grave perché non ci si sforzi di portarvi rimedio. Chi si sforza per evitare che altri soffra o si rovini, agisce con un sentimento di solidarietà che lo onora».
In Rabelais non c'è spirito litigioso. Brontola con la sua verve sarcastica contro coloro che si compiacciono di processi lunghi e rovinosi. Sono degli egoisti, degli esseri malefici che bisogna denunciare con forza, se vogliono sperare che trionfi quella dolcezza dell'anima che Rabelais oppone con grandezza. Questa bontà attiva non ha niente dell'abdicazione: al contrario essa si confonde nello spirito con quella solidarietà benefica che apre il cammino alla vittoria del buon senso e della ragione. È Panurge che canterà le lodi della solidarietà umana e pronuncerà la più bella difesa in favore dell'aiuto reciproco. Certi autori hanno tentato l'accostamento di Rabelais con il nostro Proudhon: in certi punti il riavvicinamento è spontaneo e sensato:
«Per quanto imperfetta sia questa analisi, ci accorgiamo facilmente che Rabelais aveva sulle cose in generale e sull'uomo in particolare – l'uomo considerato in se stesso o in società – idee sagge, adeguate e pratiche più di quelle correnti tra di noi e anche tra gli stessi governatori. Non è lui che si sarebbe sognato di fare dell'individuo e della società due entità indipendenti, contrastanti l'una all'altra; che avrebbe commesso l'errore di imprigionare lo spirito umano nel dilemma individualismo o socialismo, contro cui ogni giorno si scontrano i nostri uomini politici... Quanto umana e vera la dottrina di Rabelais, la cui formula è stata trovata ai nostri tempi da Pierre Leroux: l'individuo completo in una società completa».
Dallo studio sullo spirito libertario del XVI secolo, pubblicato dal mio amico Gérard de Lacaze-Duthiers, prendo questa corta citazione su Rabelais, che egli classifica tra «gli stimolatori del pensiero, tra i creatori e i realizzatori del bello», di quello stupendo XVI secolo in cui troviamo Erasmo, Jean Bodin, Michel de Montaigne, Étienne de La Boétie.
«Rabelais è uno spirito libertario, nemico dello spirito autoritario, nel pensiero e nell'azione. Rabelais è un libertario, un predecessore di Stirner e Thoreau. Egli afferma che l'individuo ha il diritto di essere se stesso, poiché, come lo proclamavano i greci, è la misura di ogni cosa e non conosce altre costrizioni che quelle che egli esercita su se stesso, altra autorità ed altre leggi che le sue; onesto, egli si astiene dall'agire in bruttezza e evolve sempre più verso l'armonia universale. Egli proclama il diritto per ciascuno di noi di vivere a suo modo, senza statuti, senza regolamenti, senza gendarmi, secondo la propria fantasia ed il proprio capriccio».
Così, dopo Nettlau, Kropotkin, Eliseo Reclus, G. Lacaze-Duthiers afferma con pertinenza l'individualismo umanista e libertario di Rabelais. Rabelais ha osato, ed è quello che è più notevole in lui, ergersi contro i grandi, contro la Chiesa così potente a quell'epoca. Egli dava prova di un forte coraggio. Bisogna ricordarsi che all'epoca in cui Rabelais si esprimeva, l'inquisizione prendeva radice e drizzava i roghi contro coloro che si permettevano qualche libertà di espressione. Bisogna ricordarsi che Étienne Dolet fu impiccato e bruciato sulla piazza Maubert nel 1546, che Louis Berque lo fu nel 1530 e che Jean Catarce, reggente dell'università di Tolosa, subì la stessa fine nella sua città nel 1532.
«Se Rabelais non fosse stato un pensatore, se fosse stato solo un narratore di facezie dove sarebbe la sua grandezza?» conclude Paul Souday, dando un resoconto di qualche opera pubblicata su Rabelais. Condivido pienamente questo giudizio sull'opera di questo grande uomo, il più grande del secolo sedicesimo. Con Rabelais il principio di autorità è fortemente scosso, il principio di libertà è prodigiosamente esaltato. Una dannata energia ed un coraggio straordinario lo caratterizzavano. Ed il Nostro se ne è servito contro la scolastica che tentava di impadronirsi dell'individuo attraverso l'educazione. È la lotta che doveva portare al trionfo dell'azione e della natura contro la reazione del tempo. Il conflitto tra la libertà e i principi d'autorità del secolo era profondo, e merito di Rabelais è di esser stato all'avanguardia in quella lotta per il trionfo del buon senso e della verità, senza cui gli uomini non possono sperare di diventare liberi e felici. Quattro secoli di scosse sociali aiutano più di tutte le parole a commentare l'opera di Rabelais. Ma Rabelais ha strappato l'uomo del suo tempo alle tenebre ed ha incitato i giovani a nutrirsi di piatti sostanziosi: «a sufficienza hai mangiato erba e fieno, lascia le vecchie cose e va!».
La lingua [1]
Le ricerche di Rabelais sulla lingua, la straordinaria ricchezza delle trovate lessicali, il gusto dei crittogrammi e dei giochi di parole, gli apporti dialettali mescolati all'uso del latino e del greco, i nonsense e la contaminazione di stili e generi diversi vanno ricondotti ai dibattiti cinquecenteschi sull'origine del linguaggio, sulla gerarchia delle lingue e sulle relazioni tra i nomi e le cose. In rapporto alle teorie linguistiche dell'epoca, l'intento di Rabelais è quello di ritrovare il senso primitivo e originario delle parole, di restituire loro l'integrità che precede la corruzione e la confusione dei segni.
Il sincretismo linguistico di Rabelais trova la sua giustificazione in una sintesi tra le idee di Aristotele sulla convenzionalità delle parole e quelle di Platone, secondo il quale i nomi sono le immagini delle cose: per Rabelais i nomi, recuperati alla loro etimologia naturale, divengono i veicoli della verità rivelata. Come è stato notato, l'uso della lingua in Rabelais implica sempre i due livelli del metaforico e del comico, e solamente questa duplice lettura consente di cogliere il significato dei prologhi, in cui la percezione immediata della risata si unisce all'interpretazione simbolica per illuminare l'oscurità del testo. Il riconoscimento di molteplici livelli presenti nel testo permette così di andare oltre la descrizione dello stile grottesco tentata da Bachtin, incentrata sugli elementi carnevaleschi dell'esagerazione, dell'iperbolicità, della buffoneria e del burlesco. Oltre alla "grammatica giocosa" e al linguaggio della vitalità, esiste in Rabelais il linguaggio del silenzio e delle "parole gelate" che rappresentano l'impossibilità presente del dire o del trovare parole adeguate al reale.