François Rabelais: differenze tra le versioni
K2 (discussione | contributi) |
K2 (discussione | contributi) |
||
| Riga 22: | Riga 22: | ||
Affrontando il discorso da un'altra prospettiva, la critica più recente ha indagato altri aspetti meno evidenti dell'opera di Rabelais, come il rapporto mai interrotto con la cultura alta rappresentata dalle fonti classiche, dal neoplatonismo e dall'evangelismo, attirando l'attenzione sull'effettiva ambivalenza dei testi e l'impossibilità di disgiungere il comico dal metafisico. A questo proposito si è notato che nel passaggio dai primi due testi dell'epopea al ''Tiers e Quart livre'', il personaggio di Pantagruel subisce un progressivo mutamento, al termine del quale perde i tradizionali attributi del romanzo picaresco desunti dalla tradizione del poema eroicomico per divenire un sovrano dotato di inalterabile dignità e perfezione morale, erede della saggezza insieme antica e moderna di Socrate e di Erasmo da Rotterdam. | Affrontando il discorso da un'altra prospettiva, la critica più recente ha indagato altri aspetti meno evidenti dell'opera di Rabelais, come il rapporto mai interrotto con la cultura alta rappresentata dalle fonti classiche, dal neoplatonismo e dall'evangelismo, attirando l'attenzione sull'effettiva ambivalenza dei testi e l'impossibilità di disgiungere il comico dal metafisico. A questo proposito si è notato che nel passaggio dai primi due testi dell'epopea al ''Tiers e Quart livre'', il personaggio di Pantagruel subisce un progressivo mutamento, al termine del quale perde i tradizionali attributi del romanzo picaresco desunti dalla tradizione del poema eroicomico per divenire un sovrano dotato di inalterabile dignità e perfezione morale, erede della saggezza insieme antica e moderna di Socrate e di Erasmo da Rotterdam. | ||
== La religione di | == La religione di Rabelais e il problema dell'incredulità nel XVI secolo == | ||
Partendo dal presupposto che nel Cinquecento l'incredulità dovuta a ragioni di ordine storico risulta un anacronismo rispetto allo spirito dell'epoca, lo storico francese Lucien Febvre ha tentato di sondare le [[religione|posizioni religiose]] di Rabelais, accusato di ateismo e di oscenità dai contemporanei, in rapporto alle correnti evangeliche e riformate del secolo. La censura che colpisce Rabelais con particolare severità nel [[1542]] secondo Febvre è collegata all'arresto dell'umanista [[Étienne Dolet]], stampatore di Gargantua e di Pantagruel e vicino agli ambienti riformati. | Partendo dal presupposto che nel Cinquecento l'incredulità dovuta a ragioni di ordine storico risulta un anacronismo rispetto allo spirito dell'epoca, lo storico francese Lucien Febvre ha tentato di sondare le [[religione|posizioni religiose]] di Rabelais, accusato di ateismo e di oscenità dai contemporanei, in rapporto alle correnti evangeliche e riformate del secolo. La censura che colpisce Rabelais con particolare severità nel [[1542]] secondo Febvre è collegata all'arresto dell'umanista [[Étienne Dolet]], stampatore di Gargantua e di Pantagruel e vicino agli ambienti riformati. | ||
| Riga 28: | Riga 28: | ||
La critica più recente ha sviluppato queste indicazioni, rilevando come uno degli esempi più accreditati dell'antimonachesimo di Rabelais e della sua satira anticlericale, la descrizione dell'abbazia utopistica di Thélème, edificata secondo il principio del libero soddisfacimento dei desideri, sia in realtà lo sviluppo narrativo di un passaggio della vita di san Girolamo di Erasmo. Lo stesso precetto del ''Fais ce que voudras'', che rappresenta l'emblema stesso di Thélème, appare come un mascheramento, in chiave umanistica e riformata, del ''Quod vis fac'' di sant'Agostino, che Rabelais reinterpreta nel senso della responsabilità del libero arbitrio indicata da Erasmo. Sotto il travestimento comico di Rabelais si cela dunque una "riscrittura" letteraria del catechismo riformato che rivela ancora una volta l'alta densità semantica del testo. | La critica più recente ha sviluppato queste indicazioni, rilevando come uno degli esempi più accreditati dell'antimonachesimo di Rabelais e della sua satira anticlericale, la descrizione dell'abbazia utopistica di Thélème, edificata secondo il principio del libero soddisfacimento dei desideri, sia in realtà lo sviluppo narrativo di un passaggio della vita di san Girolamo di Erasmo. Lo stesso precetto del ''Fais ce que voudras'', che rappresenta l'emblema stesso di Thélème, appare come un mascheramento, in chiave umanistica e riformata, del ''Quod vis fac'' di sant'Agostino, che Rabelais reinterpreta nel senso della responsabilità del libero arbitrio indicata da Erasmo. Sotto il travestimento comico di Rabelais si cela dunque una "riscrittura" letteraria del catechismo riformato che rivela ancora una volta l'alta densità semantica del testo. | ||
=== L'abbazia di Thélème: l'utopia di Rabelais === | |||
Per premiarlo del valido aiuto prestatogli nella guerra contro Pricocole, Gargantua concede a fra' Giovanni Fracassatutto di fondare un'abbazia a suo piacimento, «al contrario» di tutte le altre. La costruzione architettonica, come i costumi dei thelemiti, si ispirano a un senso di totale [[libertà]] e apertura, di raffinata gioia di vivere. La fiducia nella naturale bontà degli uomini, garantita da una libera educazione, è alla base dell'armonia di questa ideale città felice. Rabelais consacra gli ultimi sei capitoli del primo libro a Thélème. Si tratta di uno strano insieme di testi: vi si trova, con la critica del mondo monacale, una proposta di vita ideale, che non coincide però completamente con il programma educativo di Panocrate. L'episodio si chiude con una iscrizione il cui senso resta misterioso. Al tempo stesso modello ed enigma, Thélème è un luogo «altro», «diverso», un'[[utopia]], che pure non sfugge all'ottica ambigua che investe ogni episodio del romanzo. | |||
== La lingua == | == La lingua == | ||
Versione delle 19:17, 1 ott 2024

François Rabelais (Chinon, 1483 o 1494 - Parigi, 9 aprile 1553) è stato uno scrittore che meglio ha interpretato il Cinquecento francese nei suoi aspetti più inventivi e fecondi, ma anche più complessi e inquietanti. La sua arte contraddittoria e per certi versi enigmatica non cessa di affascinare per la densità linguistica e metaforica delle sue immagini, la forza creativa dei suoi paradossi, la vertigine parodica di una visione del mondo nella quale il travestimento comico non va mai disgiunto da quello simbolico. [1]
Biografia
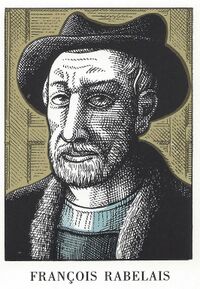
Al pari della sua opera, anche la biografia di François Rabelais presenta a tutt'oggi alcune zone d'ombra, a cominciare dalla data di nascita, incerta tra il 1483 e il 1493. Altri dubbi riguardano la sua vocazione e la scelta del monachesimo, presto abbandonato a favore della medicina e delle lettere, ma recuperato in seguito nei suoi testi dove la satira religiosa si accompagna all'affermazione più o meno scoperta delle tesi evangeliche collegate alla Riforma. È comunque all'ambito ecclesiastico che occorre rivolgersi per le prime notizie certe sulla sua vita: nel 1521 Rabelais si trova infatti nel monastero francescano di Fontenay-le-Comte, nel Poitou, dove la corrispondenza con il grande umanista Guillaume Budé testimonia uno studio assiduo della lingua e della filosofia greche. Risale a questo periodo il celebre episodio del "ratto" dei libri greci che il giovane monaco conserva nella sua cella contro le regole dell'ordinamento francescano.
È un evento significativo che testimonia l'inizio della vocazione umanistica all'origine del suo primo cambiamento di stato: dall'ordine dei Francescani a quello più intellettuale dei Benedettini. Questa soluzione tuttavia non basta a Rabelais, che di lì a qualche anno depone definitivamente la tonaca e parte alla scoperta del mondo.
Nel settembre del 1530 si iscrive alla facoltà di medicina di Mont-pellier, dove prepara un commento degli Aforismi di Ippocrate condotto sull'originale greco e attraverso nuovi manoscritti da lui ritrovati. L'interesse per la medicina, unito allo scrupolo dell'umanista che non si accontenta degli intermediari della cultura medievale, ma intende risalire all'origine delle cose e alla conoscenza dei fatti della natura, anticipa e prepara la visione rinascimentale dell'uomo come unità inscindibile di corpo e anima che pervade l'intera opera letteraria di Rabelais. Abbandonata temporaneamente la medicina, nel 1532 Rabelais pubblica il Pantagruel, primo libro delle gesta dei giganti Pantagruel e Gargantua costruito sulla parodia dei romanzi cavallereschi secondo il modello dei poemi eroicomici di Pulci e di Folengo; la seconda edizione dell'opera viene condannata per ragioni di moralità dalla Sorbona. Dopo un viaggio a Roma al seguito del vescovo e futuro cardinale Jean du Bellay, Rabelais scrive un nuovo episodio romanzesco incentrato sulla figura di Gargantua, approfittando della grande notorietà delle Croniques Gargantuines, redazioni anonime e molteplici di una leggenda popolare basata su racconti orali.
Nel 1534 esce la Vie inestimable du Grand Gargantua père de Pantagruel e viene colpita anch'essa da censura.
Solamente la protezione della famiglia Du Bellay consente a Rabelais di ottenere dal re il privilegio di pubblicare i suoi libri, peraltro sistematicamente condannati dalla Sorbona per le loro tesi apertamente rivoluzionarie e anticlericali. A questi primi due testi seguono il Tiers livre (1546), dove la ricerca irrisolta della donna ideale dell'avventuriero Panurge finisce per coincidere con la ricerca del sapere e della felicità secondo lo schema di un romanzo di formazione che ha anche i caratteri dialogici del convito socratico, e il Quart livre che, in antitesi al percorso ideale del testo precedente, narra il viaggio reale di Pantagruel e dei suoi compagni verso il santuario della Dive Bouteille, moderna parodia dell'oracolo delfico al quale chiedere il responso definitivo, e la cui sentenza paradossale ma inevitabile consiste nell'invito ad abbandonarsi al furore dionisiaco del vino. Dopo la morte di Rabelais, avvenuta nel 1553, esce postumo il frammento dell'lle sonante (1562), contenente sedici capitoli del Cinquième livre, pubblicato interamente nel 1564 e ritenuto dalla critica un rifacimento anonimo sulla base di un canovaccio dello stesso Rabelais.
Il mondo alla rovescia e il codice della parodia
Il motivo intorno al quale si concentrano l'opera e il pensiero di Rabelais è quello del viaggio, inteso metaforicamente come una riscoperta dell'uomo e del mondo. Il perenne viaggiare dei protagonisti, che mescola elementi della narrazione utopistica alla parodia delle epopee classiche e di viaggi reali (come ad esempio la spedizione di Jacques Cartier in Canada) va interpretato soprattutto come un'avventura spirituale che tende a sovvertire le gerarchie della realtà per proclamare un nuovo ordine. Nato dal caos delle forme, il gigante di Rabelais raffigura l'uomo che sceglie di dare voce ai propri desideri, intraprendendo il suo cammino di verifica e di liberazione nei riguardi della cultura mortificante dell'ascetismo e della rinuncia. L'ottimismo antropologico di Rabelais e la sua straordinaria originalità creativa si uniscono a una satira implacabile degli idola del suo tempo, dalla falsa religione alla giustizia illecita, alla cultura morta dei pedanti che limita l'universo spirituale dell'uomo, esemplificata nel catalogo esilarante della biblioteca di Saint-Victoir, parodia del sapere libresco e polveroso su cui si esercita la satira dell'umanista.
Le scelte tematiche e stilistiche di Rabelais e la vitalità esuberante della sua scrittura comica possono essere ricondotte, come fa ad esempio il critico russo Michail Bachtin, alle categorie del realismo grottesco e del carnevalesco, espressioni liberatrici e gioiose della cultura comica popolare del Medioevo, opposta alla visione ufficiale e gerarchica del mondo. Secondo Bachtin il tratto caratteristico del realismo grottesco risiede nel principio corporeo presentato nel suo aspetto materiale, comico e festoso, nel quale sono impliciti l'abbassamento e il rovesciamento dei valori tradizionali, ossia il trasferimento di tutto ciò che è alto, spirituale e astratto, sul piano materiale e corporeo.
Numerosi elementi della retorica narrativa di Rabelais, quali l'insistenza sugli atti corporei del bere, del mangiare e dell'attività sessuale, le immagini culinarie universalizzate, il ricorso al linguaggio popolare e agli stilemi della piazza, come l'ingiuria e l'esagerazione iperbolica, e soprattutto il rovesciamento parodico delle posizioni ufficiali della cultura e della religione, secondo Bachtin testimoniano l'appartenenza alla letteratura carnevalesca. Per quanto indubbiamente seducenti, le ipotesi di Bachtin svelano il lato più scopertamente vitalistico del comico in Rabelais, ma non ne esauriscono tutte le valenze.
Affrontando il discorso da un'altra prospettiva, la critica più recente ha indagato altri aspetti meno evidenti dell'opera di Rabelais, come il rapporto mai interrotto con la cultura alta rappresentata dalle fonti classiche, dal neoplatonismo e dall'evangelismo, attirando l'attenzione sull'effettiva ambivalenza dei testi e l'impossibilità di disgiungere il comico dal metafisico. A questo proposito si è notato che nel passaggio dai primi due testi dell'epopea al Tiers e Quart livre, il personaggio di Pantagruel subisce un progressivo mutamento, al termine del quale perde i tradizionali attributi del romanzo picaresco desunti dalla tradizione del poema eroicomico per divenire un sovrano dotato di inalterabile dignità e perfezione morale, erede della saggezza insieme antica e moderna di Socrate e di Erasmo da Rotterdam.
La religione di Rabelais e il problema dell'incredulità nel XVI secolo
Partendo dal presupposto che nel Cinquecento l'incredulità dovuta a ragioni di ordine storico risulta un anacronismo rispetto allo spirito dell'epoca, lo storico francese Lucien Febvre ha tentato di sondare le posizioni religiose di Rabelais, accusato di ateismo e di oscenità dai contemporanei, in rapporto alle correnti evangeliche e riformate del secolo. La censura che colpisce Rabelais con particolare severità nel 1542 secondo Febvre è collegata all'arresto dell'umanista Étienne Dolet, stampatore di Gargantua e di Pantagruel e vicino agli ambienti riformati.
D'altro canto nell'opera di Rabelais vi sono numerosi riferimenti al catechismo dei riformatori, quali gli accenni al Vangelo come unica guida contro l'abuso dei falsi profeti, l'abolizione di un culto ostentato a favore della preghiera interiore, gli echi del pensiero di Lutero e soprattutto di Erasmo, mentre risulta evidente la sua condanna dell'intolleranza di Calvino.
La critica più recente ha sviluppato queste indicazioni, rilevando come uno degli esempi più accreditati dell'antimonachesimo di Rabelais e della sua satira anticlericale, la descrizione dell'abbazia utopistica di Thélème, edificata secondo il principio del libero soddisfacimento dei desideri, sia in realtà lo sviluppo narrativo di un passaggio della vita di san Girolamo di Erasmo. Lo stesso precetto del Fais ce que voudras, che rappresenta l'emblema stesso di Thélème, appare come un mascheramento, in chiave umanistica e riformata, del Quod vis fac di sant'Agostino, che Rabelais reinterpreta nel senso della responsabilità del libero arbitrio indicata da Erasmo. Sotto il travestimento comico di Rabelais si cela dunque una "riscrittura" letteraria del catechismo riformato che rivela ancora una volta l'alta densità semantica del testo.
L'abbazia di Thélème: l'utopia di Rabelais
Per premiarlo del valido aiuto prestatogli nella guerra contro Pricocole, Gargantua concede a fra' Giovanni Fracassatutto di fondare un'abbazia a suo piacimento, «al contrario» di tutte le altre. La costruzione architettonica, come i costumi dei thelemiti, si ispirano a un senso di totale libertà e apertura, di raffinata gioia di vivere. La fiducia nella naturale bontà degli uomini, garantita da una libera educazione, è alla base dell'armonia di questa ideale città felice. Rabelais consacra gli ultimi sei capitoli del primo libro a Thélème. Si tratta di uno strano insieme di testi: vi si trova, con la critica del mondo monacale, una proposta di vita ideale, che non coincide però completamente con il programma educativo di Panocrate. L'episodio si chiude con una iscrizione il cui senso resta misterioso. Al tempo stesso modello ed enigma, Thélème è un luogo «altro», «diverso», un'utopia, che pure non sfugge all'ottica ambigua che investe ogni episodio del romanzo.
La lingua
Le ricerche di Rabelais sulla lingua, la straordinaria ricchezza delle trovate lessicali, il gusto dei crittogrammi e dei giochi di parole, gli apporti dialettali mescolati all'uso del latino e del greco, i nonsense e la contaminazione di stili e generi diversi vanno ricondotti ai dibattiti cinquecenteschi sull'origine del linguaggio, sulla gerarchia delle lingue e sulle relazioni tra i nomi e le cose. In rapporto alle teorie linguistiche dell'epoca, l'intento di Rabelais è quello di ritrovare il senso primitivo e originario delle parole, di restituire loro l'integrità che precede la corruzione e la confusione dei segni.
Il sincretismo linguistico di Rabelais trova la sua giustificazione in una sintesi tra le idee di Aristotele sulla convenzionalità delle parole e quelle di Platone, secondo il quale i nomi sono le immagini delle cose: per Rabelais i nomi, recuperati alla loro etimologia naturale, divengono i veicoli della verità rivelata. Come è stato notato, l'uso della lingua in Rabelais implica sempre i due livelli del metaforico e del comico, e solamente questa duplice lettura consente di cogliere il significato dei prologhi, in cui la percezione immediata della risata si unisce all'interpretazione simbolica per illuminare l'oscurità del testo. Il riconoscimento di molteplici livelli presenti nel testo permette così di andare oltre la descrizione dello stile grottesco tentata da Bachtin, incentrata sugli elementi carnevaleschi dell'esagerazione, dell'iperbolicità, della buffoneria e del burlesco. Oltre alla "grammatica giocosa" e al linguaggio della vitalità, esiste in Rabelais il linguaggio del silenzio e delle "parole gelate" che rappresentano l'impossibilità presente del dire o del trovare parole adeguate al reale.
Note
- ↑ Fonte principale della voce: Storia della civiltà europea a cura di Umberto Eco.